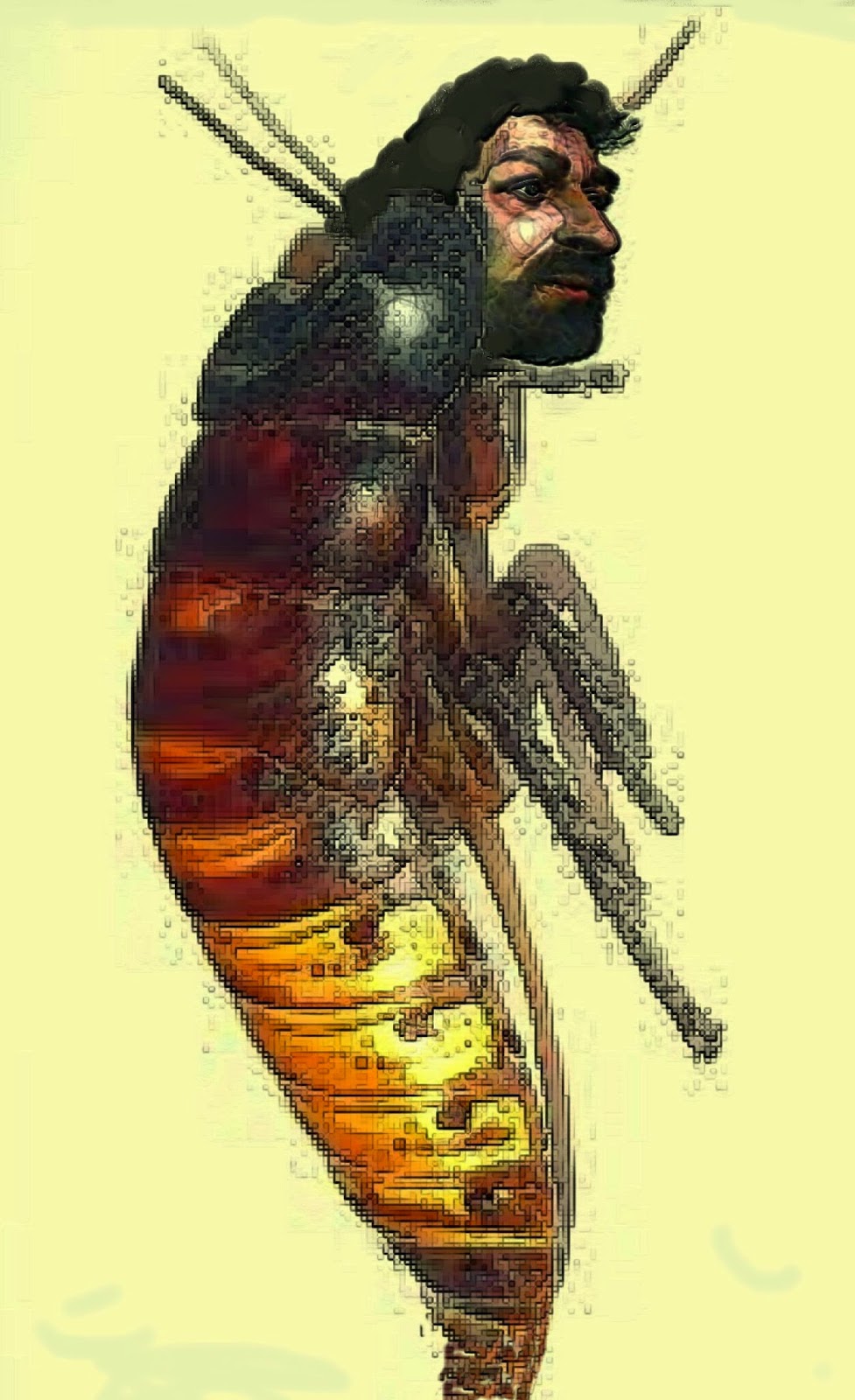Gli spari
cessarono.
Henry
Booth si sedette sul pavimento, la schiena appoggiata alla parete e lo sguardo
rivolto all’interno del locale. Teneva fra le mani il suo Winchester ancora
caldo. Aveva gli occhi arrossati, pieni di rabbia e di pianto.
Dalla
piccola stanza adiacente veniva il lamento di Diana. La moglie stava prestando
le sue cure alla piccola April, ma le parole si erano trasformate in singulti e
gemiti. Alla finestrella dello stesso locale era appostato Keith, il dodicenne
primogenito. Maneggiava con abilità una vecchia doppietta, dando filo da
torcere agli assalitori.
Un gruppo
di apaches della banda di Chokon aveva circondato la piccola fattoria. Non
erano più di una decina. Due erano caduti già sotto il fuoco dei difensori, ma
gli altri erano vivi e vegeti, pronti a dare l’ultimo assalto.
Henry
considerò la situazione e pensò che doveva vendere cara la pelle e quella dei
suoi famigliari. Per la piccola April c’erano ormai poche speranze. Lo aveva
capito subito quando, due ore prima, l’aveva portata in casa fra le braccia. La
bimba, che stava dando da mangiare alle oche, era stata colpita da una delle
prime pallottole indiane.
Gli
uomini di Chokon erano sbucati dal rado boschetto lungo il torrente, dove
avevano lasciato i cavalli. Forse erano ubriachi. I Booth erano riusciti a
chiudersi in casa e avevano cominciato a difendersi.
Ora gli
apaches erano diventati più prudenti.
- No, mio
Dio, noo! – gridò Diana.
Henry
rivolse un’occhiata furtiva alla finestra dai vetri infranti e poi raggiunse la
moglie.
- È
morta, è morta! - gridava la donna.
Keith
scoppiò a piangere.
April era
distesa sul lettino. La sua lunga treccia color del miele le scendeva sul vestitino
verde, qua e là sporco di terriccio.
Erano
sulla sommità della collina, quando il giovane sottotenente Branch alzò il
braccio destro e ordinò di fermarsi.
Da
quell’altura si vedeva l’ondulata pianura verso Santa Fè, la città alla quale era
diretta la pattuglia di quindici cavalleggeri, proveniente da Fort Stanley.
Ritti sui
loro cavalli, i soldati osservarono il panorama. Due falchi si inseguivano in
un cielo azzurro e limpido. L’aria, in quel punto, era gradevolmente ventilata;
la calura della giornata estiva era più sopportabile.
-
Caporale – disse Branch al militare che gli stava accanto, - facciamo qui una
breve sosta. Voglio arrivare in città prima di sera.
-
Signorsì, signore – rispose il graduato, togliendosi il berretto per asciugarsi
il sudore dalla fronte.
Cavalcava
con loro un certo Samuel Scott, sensale nel settore bestiame. Approfittava
della scorta di quel drappello per viaggiare sicuro fino a Santa Fè. Con la
banda di Chokon in circolazione bisognava essere prudenti.
- Sapete
meglio di me, tenente – aveva detto a Branch prima di aggregarsi a loro, - che
quei maledetti Apaches stanno facendo colpi di mano sempre più vicino alla
città. Da quando è iniziato questo benedetto 1879, ne hanno già combinate di
tutti i colori.
Smontarono da cavallo, mentre un serpente a sonagli scivolava silenzioso
dietro un grosso cactus.
Henry
Booth aprì il fuoco. Fece scattare la molla di ricarica altre due volte e
lasciò partire i colpi a breve intervallo. Ma l’indiano preso di mira si gettò
a terra, dietro la staccionata. E ora sparava a sua volta con la vecchia
carabina.
Anche
Keith sparava dalla finestrella sul retro, nella stanzetta dove la madre
piangeva, abbandonata sul corpo della piccola April.
- Ne ho
beccato uno! – gridò a un tratto il ragazzo.
-
Coraggio, figliolo – lo incoraggiò il padre. – Ma tieniti bene a riparo.
Henry non
si faceva troppe illusioni. Gli indiani prima o poi avrebbero avuto il
sopravvento, sarebbero riusciti a entrare in casa. E le pallottole cominciavano
a scarseggiare.
Solo un
miracolo avrebbe potuto salvarli.
Improvvisamente gli Apaches cessarono ancora una volta di combattere e
rimasero nascosti nelle loro postazioni. Era la loro strategia: logorare i
nervi degli assediati.
Passò una
buona mezzora di silenzio surreale. Il sole era alto nel cielo.
Poi
ripresero gli spari.
Due
indiani si avvicinarono con grandi scatti felini e si gettarono dietro la vasca
dell’acqua.
- Papà,
ho finito le cartucce.
Lui non
gli rispose. Prese la mira e fece fuoco, colpendo un indiano che non se ne
stava troppo al coperto dietro il carro.
Ne
rimanevano almeno sei, che non avrebbero mollato la loro preda.
Altra
pausa. Solo dopo un bel momento cominciò quello che sembrava l’assalto
definitivo.
In quel
momento avvenne il miracolo.
Si udì un
ripetuto squillo di tromba. Sul debole crinale al di là del torrente apparve un
gruppo di uomini a cavallo, in giacca blu.
- I
soldati – gridò Keith che li aveva visti per primo.
* * *
Samuel
Scott rimase molto impressionato da quella vicenda. Ne parlò per molti anni.
Anche
lui aveva visto la bimba con il vestitino verde, là sulla collina rinfrescata
dalla brezza. Era come spuntata dal nulla. Piangeva. Diceva, con una vocina
esile che sembrava sentirsi dappertutto:
- Venite
ad aiutare la mia famiglia! Gli indiani sparano alla mia casa, laggiù lungo il
torrente. – E indicava con la manina la direzione.
Poi si
era messa a correre lungo il pendio.
- Ehi,
bambina! – l’aveva richiamata il caporale.
Il
tenente aveva fatto due o tre passi nel tentativo di ricorrerla.
Ma lei
era scomparsa fra i cespugli.
- In
sella! – aveva ordinato l’ufficiale.
Nel cercare
di ritrovare la piccola, avevano cavalcato per circa mezzora, finché avevano
udito gli spari.
Avevano
ucciso quei sei indiani, prima che se la fossero data a gambe.
E così
l’avevano rivista, la bambina, cadavere nel suo lettino.
Henry Booth
aveva stentato a credere al resoconto dei soldati. La moglie, invece, aveva
detto tra i singhiozzi:
- La mia
bambina è diventata un angelo… e ha vegliato su di noi.
Il marito
l’aveva abbracciata.
Scott, il
sensale, aveva guardato con aria interrogativa il giovane Keith e gli aveva
chiesto, alludendo alla vecchia doppietta:
- Hai
sparato con quella?
- Sì, ne
ho beccati due.
- Una
bella fortuna hai avuto, ragazzo. Un vero miracolo.